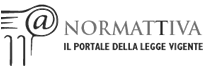“Chi porta o fa portare il burqa non può diventare cittadino francese”.
Possono sintetizzarsi così i titoli degli articoli, apparsi nelle scorse settimane, a seguito del rifiuto – da parte del ministro francese dell’immigrazione Eric Besson – di concedere la cittadinanza transalpina  ad uno straniero che obbligava la moglie, francese, ad indossare il velo integrale.
ad uno straniero che obbligava la moglie, francese, ad indossare il velo integrale.
Questa decisione fa seguito – sempre in Francia – ad analogo diniego, espresso in un parere del Consiglio di Stato, nei confronti di una donna marocchina avvolta nel suo burqa.
Le motivazioni dell'avversione del Governo di Parigi per l’ormai arcinoto capo di abbigliamento tradizionale delle donne di alcuni Paesi di religione islamica spaziano dalla presunta violazione del diritto di eguaglianza delle donne, alla qualificazione di simbolo dell’oppressione maschile, all’infrazione delle norme di ordine pubblico che vietano il celamento del viso nei luoghi pubblici, sino all’incompatibilità “con i valori essenziali della comunità francese” (così il Consiglio di Stato francese).
Il presidente Sarkozy ha statuito perentoriamente che il burqa e il niqab (versione di velo integrale che lascia scoperti gli occhi, più diffuso in occidente) “non saranno mai benvenuti sul territorio della Repubblica francese”.
Potrebbe accadere qualcosa di analogo in Italia? Potrebbe accadere che sia negata la cittadinanza in simili casi?
La legge che regola l’acquisizione della cittadinanza italiana è la numero 91 del 5 febbraio 1992. Contempla svariate fattispecie di acquisto (nonché di perdita e riacquisto) della cittadinanza italiana: per nascita da cittadino italiano, per nascita in territorio italiano, per riconoscimento della filiazione, per discendenza da straniero di origine italiana, per matrimonio con italiano, ecc.).
L’ipotesi che qui interessa (e, negli ultimi anni, più frequente) è quella generalmente detta della naturalizzazione (art. 9 L. 91/1992), in base alla quale allo straniero “può essere concessa” la cittadinanza italiana ove sussistano una serie di requisiti, primo fra i quali un lungo periodo di residenza legale in Italia (per gli stranieri extracomunitari, 10 anni).
La formula usata dal legislatore e l’applicazione che è seguita della norma richiamata rendono evidente che ci si trova di fronte ad un provvedimento di concessione, avente efficacia costitutiva del nuovo status di cittadino italiano, in cui il rispetto di alcuni requisiti formalmente stabiliti lascia aperto il varco ad una valutazione discrezionale, da parte della pubblica amministrazione, se concedere o meno l’ambìto fascio di diritti civili e politici connessi all’essere italiano.
La definizione di questa ampia zona valutativa discrezionale è stata, nel tempo, meglio precisata dai pareri del Consiglio di Stato e dalla giurisprudenza amministrativa, giacché la legge, come si diceva, si limita ad escludere che la concessione possa avvenire nei confronti di chi risieda sul territorio nazionale da tempo inferiore a quello prefissato, di chi abbia subito condanne penali per determinati reati di una certa gravità, o di chi metta a repentaglio la sicurezza della Repubblica.
Se si escludono i primi due requisiti (residenza, assenza di condanne per fattispecie criminose predeterminate) che non lasciano adito ad eccessivi dubbi applicativi, il diniego della concessione per comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, che muove da considerazioni sicuramente più elastiche e sfuggenti ad una predeterminazione casistica, richiede una valutazione, circa il grado di probabilità di esiti pericolosi per la sicurezza della comunità statuale, che non necessita di una doviziosa esternazione di fatti e circostanze posti a suo fondamento. Invero, la giurisprudenza amministrativa, in questi casi, si limita ad una verifica del rispetto dell’obbligo di motivazione del provvedimento denegativo, che può limitarsi alla esposizione sommaria delle ragioni, riscontrate nel caso concreto, poste alla base del diniego.
Accanto a questi requisiti normativamente elencati, l’attività amministrativa, col suggello dei TAR e del Consiglio di Stato, ha enucleato una serie di ulteriori aspetti oggetto di verifica nell’istruzione delle domande di cittadinanza: il possesso di adeguate fonti di sussistenza, la serietà dell’intento di ottenere la cittadinanza italiana (anche alla luce delle ragioni che inducono all’abbandono della comunità d’origine), il grado di conoscenza della lingua italiana, l’idoneità professionale, l’ottemperanza ad obblighi tributari, riassumendo in una locuzione: il grado di inserimento, integrazione nella comunità nazionale.
Può non essere superfluo precisare che, scorrendo l’intero testo della legge 91 del 1992, e di tutti i suoi regolamenti attuativi, non si rinvengono occorrenze dei termini “inserimento” o “integrazione”, né, tanto meno, i valori cui alludono i massimi esponenti del governo o il Consiglio di Stato transalpini, facendo leva sull’espressa previsione della normativa francese (da ultimo modificata con la legge 911 del 2006) del requisito “della sufficiente conoscenza della lingua, e della verifica di casi di indegnità o difetto di assimilazione, ostativi alla naturalizzazione”.
Ma anche in Italia, seppur per via amministrativa e giurisprudenziale, si giunge al medesimo risultato, allorquando si costruisce il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana come “esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell’Amministrazione che è tenuta ad accertare la coincidenza tra l’interesse pubblico da tutelare e quello vantato dal richiedente, mediante una valutazione complessiva dell’impatto che avrebbe sull’ordinamento l’attribuzione a titolo stabile dello status civitatis e evitando che dalla concessione possa derivarne danno o nocumento all’ordinamento nazionale”.
Questa è la formula frequentemente adoperata dal Ministro dell’Interno nel rigettare le richieste di cittadinanza italiana al di fuori delle cause ostative espressamente previste dalla legge (residenza infra-decennale, condanne, pregiudizio alla sicurezza della Repubblica). Si torna, quindi, al quesito inziale: potrebbe essere adottata la stessa formula per respingere la domanda presentata da chi indossa il burqa?
I parametri individuati possono sostanzialmente ridursi ad uno: l’impatto (danno o nocumento) che l’attribuzione della cittadinanza, in questo caso, avrebbe sull’ordinamento nazionale.
Qualcuno potrebbe sostenere che non può integrare un danno o una violazione dell’ordinamento nazionale l’uso di simboli religiosi, e, quindi, una delle tante manifestazioni di esercizio della libertà religiosa garantita dagli articoli 8 e 19 della nostra Costituzione.
Questa obiezione sconta, però, il problema della non generalmente riconosciuta natura di simbolo religioso attribuita al burqa, a differenza di altri indumenti, quali chador, kippah ebraica e turbanti sikh. Senza citare autorevoli interpretazioni coraniche di elevatissime cariche religiose islamiche, nel mondo musulmano appare prevalente l’inquadramento del burqa nell'ambito dei costumi sociali di limitate popolazioni, piuttosto che assolvimento di un precetto di Maometto.
Ma si ammetta, per un momento, che sia accettato l’orientamento di chi vi scorge l’esercizio, più o meno proselitico, del diritto alla libera professione del proprio credo religioso.
Possono comunque profilarsi attriti con la normativa italiana?
Il pensiero corre subito all’articolo 85 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) il quale, perentoriamente, recita: “È vietato comparire mascherato in luogo pubblico”. Si tratta di una contravvenzione punita con una modesta sanzione amministrativa pecuniaria, che fa il paio con l’altra contravvenzione (questa, però, punita penalmente con arresto e ammenda) sancita dall’articolo 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico): “È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino”.
In particolare quest’ultima disposizione, varata negli anni di piombo, è tornata particolarmente in auge nei recenti anni caratterizzati dal rischio di attentati di matrice islamica fondamentalista, e mira a garantire ciò che il burqa, per definizione, impedisce: il riconoscimento del volto.
La questione della possibile collisione tra esercizio della libertà religiosa e rispetto dell’ordine pubblico (altro valore costituzionalmente garantito) è stata risolta dalla Corte Costituzionale italiana già negli anni sessanta (sentenza 16 marzo 1962, n. 19) statuendo che “sono pertanto costituzionalmente legittime le norme che effettivamente, ed in modo proporzionato, siano rivolte a prevenire e a reprimere i turbamenti all’ordine pubblico (intesi come insorgere di uno stato concreto ed effettivo di minaccia all’ordine legale mediante mezzi illegali idonei a scuoterlo) eventualmente anche mediante la limitazione di altri diritti costituzionalmente garantiti”.
Esempio di questo bilanciamento di valori e diritti costituzionalmente presidiati è dato, in un caso perfettamente sovrapponibile alla questione del burqa, da una interpretazione data dal Ministero dell’Interno (in una circolare del dipartimento della pubblica sicurezza del 24 luglio 2000) all’applicazione della normativa in tema di rappresentazione fotografica da applicare sulle carte d’identità con riguardo a persone, la cui religione imponga l’uso continuo del copricapo.
Nella circolare citata si afferma che, nell’ipotesi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, “sono ammesse… le fotografie da inserire nei documenti d’identità in cui la persona è ritratta con il capo coperto da indumenti indossati purché, ad ogni modo, i tratti del viso siano ben visibili”.
Sembrerebbe, quindi, palese che il burqa, in tal caso, a differenza di altri capi d’abbigliamento religiosi, sia fuorilegge.
Si tratterebbe, allora, dell’individuazione di una violazione al nostro ordinamento, che potrebbe essere considerata ostativa alla concessione della cittadinanza. Quanto meno nell’uso pubblico, nel senso di rapporto con le pubbliche autorità, che si volesse fare del velo integrale.
E se, invece, il burqa fosse indossato solo privatamente, nei rapporti sociali privi di contatto con pubblici ufficiali? Potrebbe, in tal caso, essere additato come strumento di nocumento all’ordinamento, al civile e ordinato svolgersi della vita collettiva?
Va intanto precisato che chi indossa il burqa lo fa per rispettare un precetto, sia o meno di natura religiosa; la donna che lo porta, quindi, non ha facoltà di portarlo o toglierlo, nei rapporti sociali, a seconda delle contingenze o convenienze.  Il discorso, sotto questo aspetto, è simile a quello già affrontato, negli anni passati, a proposito delle violazioni amministrative commesse dagli indiani sikh, impossibilitati all’uso del casco protettivo alla guida del loro motociclo o nei cantieri edili, ed inseparabili dal kirpan, il loro pugnale ricurvo.
Il discorso, sotto questo aspetto, è simile a quello già affrontato, negli anni passati, a proposito delle violazioni amministrative commesse dagli indiani sikh, impossibilitati all’uso del casco protettivo alla guida del loro motociclo o nei cantieri edili, ed inseparabili dal kirpan, il loro pugnale ricurvo.
Occorre, pertanto, verificare se possa considerarsi ostativa al conseguimento della cittadinanza la puntuale osservanza del precetto che impone di indossare il burqa, indipendentemente dalla intervenuta contestazione di una qualsiasi infrazione amministrativa o penale.
Qui si apre il varco alla vera questione sottesa al caso burqa, che è fondamentalmente una questione culturale e valoriale, o meglio di compatibilità tra “valore” connesso al rispetto di quel precetto e valori alla base del nostro ordinamento.
Questo tipo di ponderazione – ammissibile nel procedimento di concessione della cittadinanza, come visto in precedenza, per l’ampia portata della discrezionalità che lo caratterizza – può assumere connotati e risultati diversi a seconda dei periodi storici, e di quali siano i soggetti chiamati a decidere, “interpretando” i principi della civile convivenza nella società italiana, a partire dal dato formale costituito dai diritti e dalle libertà costituzionalmente garantite.
Se questo processo logico è corretto, il responso alla domanda di partenza (Chi porta il burqa non può diventare cittadino italiano?) dovrebbe derivare, innanzitutto, dalla verifica del grado di consapevolezza nel comportamento di chi indossa il velo; al fine di escludere che ci si trovi dinanzi ad una evidente compressione della più antica delle libertà riconosciute negli stati occidentali, la libertà personale. Infatti, non può non vedersi nell’imposizione del velo integrale una sostanziale restrizione della libertà della persona, ammessa dal nostro ordinamento solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Se non, addirittura, una vera e propria violenza morale sulle donne.
Tuttavia, si potrebbe negare – come sembra sia stato fatto in Francia – un beneficio quale la concessione della cittadinanza ad una persona solo perché vittima di violenza, o comunque privata – seppur in parte – della propria libertà personale fuori dai casi consentiti dalla Costituzione e dalla legge? A ben vedere, lo stesso discorso dovrebbe riguardare anche quei richiedenti la cittadinanza che vivano una condizione di grave subalternità, in famiglia, sul lavoro, nella comunità sociale di appartenenza, a prescindere dall’uso di un determinato capo di vestiario.
Evidentemente, il problema non è davvero questo. Lo si comprenderebbe soprattutto se si esaminasse il caso di donne che ritengono di indossare il burqa “per libera scelta” (omnia munda mundis…), o per consapevole atto di ossequio alle proprie credenze religiose.
Una situazione simile fa emergere la vera natura dello scontro in atto nella diatriba burqa sì-burqa no, ossia la fortissima carica simbolica che il velo integrale porta con sé.
Cos’è il burqa, per noi occidentali, se non il simbolo di uno scontro di civiltà, il simulacro di un viaggio a ritroso nel tempo, di un ritorno ad epoche pre-moderne, caratterizzate da pratiche discriminatorie e dalla negazione di un ruolo pubblico per gli appartenenti al genere femminile?
Sempre in tema di confronto con altri mondi, e rimanendo in materia di costumi, potremmo provare a rovesciare iperbolicamente i termini del problema, ed arriveremmo 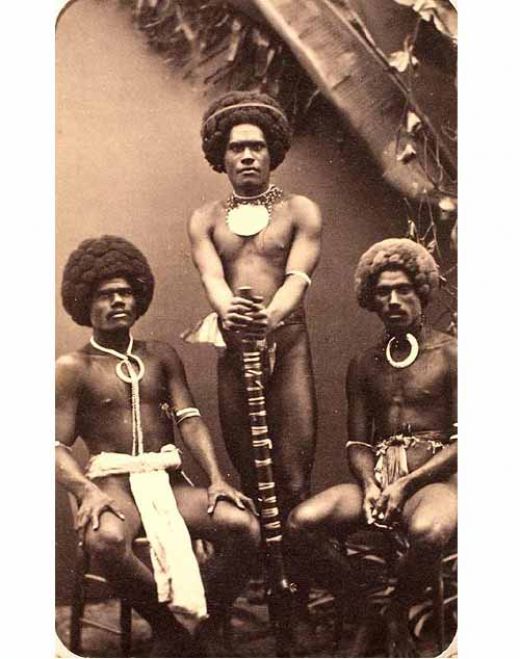 a conclusioni analoghe se la pratica, anziché nel coprire tutto il corpo, consistesse nel lasciare ignuda la persona, ed invece che simbolo di oppressione di genere si rivelasse più funzionale al pieno raggiungimento dell’identità psichica e sociale femminile, come nelle popolazioni adolescenziali samoane studiate da Margaret Mead.
a conclusioni analoghe se la pratica, anziché nel coprire tutto il corpo, consistesse nel lasciare ignuda la persona, ed invece che simbolo di oppressione di genere si rivelasse più funzionale al pieno raggiungimento dell’identità psichica e sociale femminile, come nelle popolazioni adolescenziali samoane studiate da Margaret Mead.
In conclusione, si può ben dire che la questione legata all’uso del burqa offre molteplici spunti di riflessione, leggendo la nostra Carta Costituzionale, circa il rispetto dei diritti di libertà previsti dall’articolo 13, e più in generale la salvaguardia del principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3, per il quale la pari dignità dell’individuo deve essere propedeutica al pieno sviluppo della persona umana e all’effettiva partecipazione all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Principi rispetto ai quali il valore sotteso al diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, riconosciuto dall’articolo 19 della Costituzione italiana, si rivela recessivo.
Quando, però, si affronta il problema della ostatività o meno di comportamenti, credenze, pratiche ai fini dell’ottenimento della cittadinanza, inevitabilmente, la valutazione subisce una trasposizione su un piano più ampio, legato all’idea e all’immagine che una comunità ha di se stessa, e al ruolo che si pensa (o si pretende) debbano interpretare i suoi membri.
24 marzo 2010